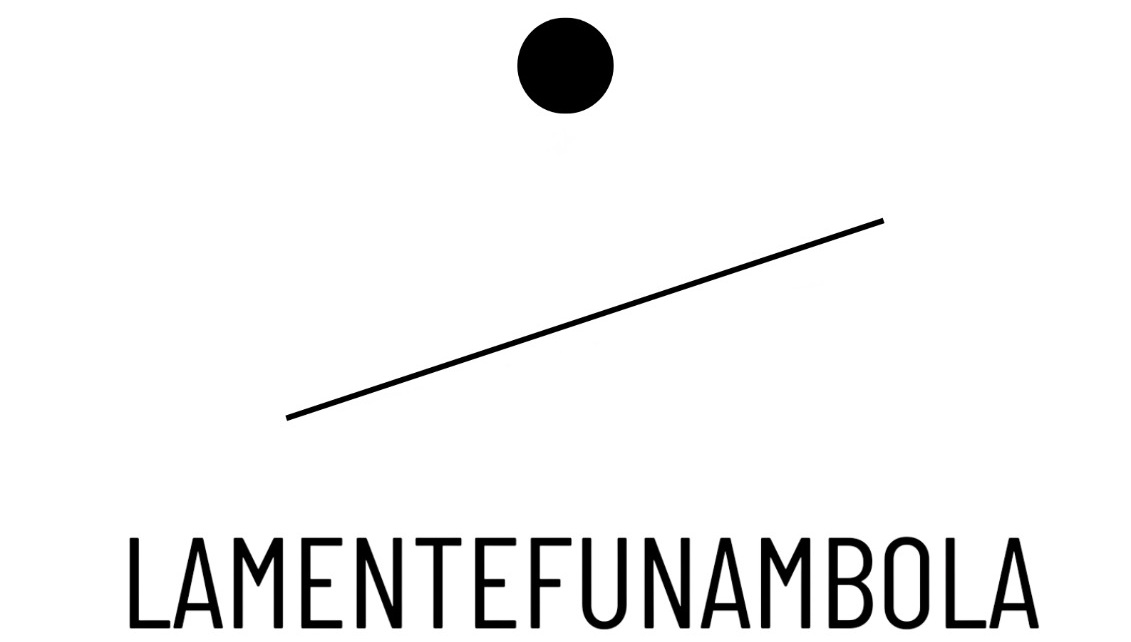L’espressione Sàpere àude – osa essere saggio- viene da una delle Epistole di Orazio in cui, rivolgendosi a Massimo Lollio, console romano, lo esorta a risolversi a essere saggio, studioso e onesto.
Il medesimo enunciato ritorna altre volte nella storia del pensiero umano sebbene indicando proposizioni leggermente diverse, ne indichiamo qui di seguito alcune particolarmente significative per la tesi qui esposta.
Nel 1784 Immanuel Kant nel suo ‘ Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?’ la riprende testuale pur modificandone la sfumatura di significato, indicando con essa il coraggio di usare la propria intelligenza, trasformando così questa espressione in cifra e motto dell’illuminismo.
Nel 2011 Martha Nussbaum nel suo manifesto democratico ‘ Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica’ pur senza usare le medesime parole parafrasa il concetto sostenendo le ragioni del sapere umanistico come strumento essenziale di sopravvivenza democratica.
Nel 2019 Ivano Dionigi lo pone, in traduzione italiana, a titolo di un suo breve e denso saggio ‘ Osa sapere. Contro la paura e l’ignoranza’ in cui, fra l’altro, si argomenta a favore degli studi umanistici, essenziali, nel porre la domanda se tutto ciò che è possibile si debba anche fare, proprio in quest’epoca in cui tecnica ci consente di superare confini del possibile finora impensabili.
Il sapere che con diverse sfumature e applicazioni gli esempi qui sopra esortano ad abbracciare coraggiosamente non è quello riconosciuto comunemente come potente, dominante e specialistico della scienza e della tecnica ma quello, percepito come privilegiato e spesso ozioso, poetico, variegato e complesso delle humanites di cui la filosofia è, e non solo dal mio fazioso punti di vista, punta di diamante.
E’ il sapere necessario alla formazione della persona, prima che del professionista, nella consapevolezza che è la postura etica e valoriale personale quella che sorregge e permea anche quella fattiva e fattuale del lavoro.
Una volta, nella cultura italiana, era un fatto assodato la compresenza di entrambi i saperi, di entrambe le culture, umanistica e scientifica, nelle loro più ampie accezioni, anche nelle professioni più tecniche. Era bagaglio culturale comune lo studio e la riflessione dei classici, l’educazione alla bellezza e alla letteratura nelle sue più disparate forme…ma quella era una realtà fortemente elitaria in cui l’appannaggio della cultura era condensato in poche realtà e professioni e al resto della forza lavoro restava più che altro l’accesso agli approfondimenti tecnici specialistici e chiaramente la possibilità di coltivare il resto autonomamente o in famiglia…alimentando ancora di più la sperequazione della cultura.
Con il tempo si è cercato di smantellare la fortezza della cultura alta, in modo che i suoi saperi e i suoi sapori potessero diffondersi e diventare fruibili raggiungibili da tutti, non solo da chi aveva il destino tracciato in tal senso.
Ma come spesso, se non sempre, accade anche le migliori teorie e intenzioni mutano una volta diventate pratica e qualora vengano portate avanti in modo troppo spinto o troppo velocemente o con troppa foga creano contraddizioni e conseguenze indesiderate se non inaccettabili…e così la cultura classica, le humanites (con la sola eccezione della psicologia che ha saputo cogliere l’occasione e la missione divulgativa) anziché diffondersi acquisendo nuovi linguaggi e mezzi per parlare, affascinare, formare più persone possibili si sono via via rintanate nelle accademie mentre le scienze e le tecniche si diffondevano a macchia d’olio con gli effetti, sul piano esistenziale e professionale, che assistiamo quotidianamente,
Negli anni la filosofia ha riscoperto un aspetto essenziale della sua vocazione che affianca alla ricerca il confronto con la realtà. Una riscoperta filosofia di piazza in cui il filosofo ritorna a interrogare, porsi in dialogo con le persone su qualsiasi tema prema o sia di interesse.
Nasce così la pratica filosofica che pian piano prende spazio e rivendica il suo posto sotto il sole, e non solo nelle aule delle università.
La pratica filosofica si propone negli incontri individuali come sessioni di counseling, si affianca in equipe con altre discipline nel guardare a situazioni cliniche, di recupero, di riparazione, parla alle e nelle aziende offrendo metodi e sguardi diversi da quelli già presenti di coaching e gestione delle risorse umane, dialoga con i bambini e i ragazzi consapevole che cambiando registro essi sono interlocutori adatti alle domande e alle indagini filosofiche.
Oltre a queste, più impegnative e mirate, esiste anche tutto un universo di pratiche filosofiche mondane, pratiche dialogiche più informali, tenute in contesti e con pretesti più ludici e di intrattenimento come i café-philò di cui Marc Sautet è stato pioniere e punto di riferimento, gli ape-philò e cene filosofiche, ma anche i cine-philò, le passeggiate filosofiche, etc.
A queste si è affiancato nel tempo il fenomeno della pop-filosofia di stampo partecipativo e divulgativo, arrivando a coinvolgere moltissime persone in festival e nell’ascolto di podcast, portando la filosofia a una fama e successo direi mai sperimentata prima.
Ma non si tratta tanto di riprendere o intraprendere gli studi classici per completare la propria formazione, sebbene la divulgazione sia sicuramente un aspetto dell’apertura della filosofia “verso la strada” così come l’educazione al gusto e alla bellezza aiutano a riempire di colori e spessori diversi come percepire l’esistenza, ciò che nel contesto della missione e vocazione della pratica filosofica, così come viene intesa e vissuta da chi scrive, costituisce oggi l’invocazione del titolo è l’acquisizione di una certa postura filosofica il coraggio di sapere diventa il coraggio di intraprendere un percorso di consapevolezza, il coraggio di aprirsi e riaprirsi alle possibilità proprie dell’essere umano, guardando con responsabilità alle miserie e nobiltà date dal grande potere dell’umanità…pensiero, azione, volontà.
Il sapere aude non indica quindi riempirsi di citazioni o cambiare i propri gusti letterari, né rinunciare ad alcune forme di intrattenimento piuttosto che altre, si tratta invece di avere il coraggio di abbracciare la propria umanità nella sua complessa completezza…e noi siamo anche riflessione e non solo reazione, siamo anche autonomia e non solo aggregazione, siamo anche inquieti e non solo funzionali , siamo contraddizione e non solo costruita coerenza, ect.
Diventare consapevoli di queste sfaccettature, abbracciarle, imparare a guardarle, esplorarle, viverle, interrogarle in dialogo con i contesti in cui viviamo, conoscendo i diversi contesti e collegando i nostri pensieri con i pensieri pensati da altri esseri umani nel corso della storia dell’umanità, mantenendo un atteggiamento scevro dal pregiudizio, imparando a maneggiare il giudizio e a sostenere le proprie posizioni correttamente in un clima di ragionevolezza e ascolto reciproco, veicolando le parti più irrazionali in modo non lesivo e mantenendosi aperti a tutto ciò che ancora non possiamo sapere ma che potrebbe emergere e diventare argomento di analisi sono alcune delle competenze e degli allena-menti propri della postura filosofica che non giudica né cambia la propria vita ma la amplia rendendoci padroni di pensieri lunghi, facendoci scoprire una maggiore varietà di piaceri, armandoci di competenze atte a sostare o comprendere o attraversare i dolori, le situazioni le fatiche delle nostre esistenza.
Non si tratta di una terapia, né di una mera conoscenza, non ha come fine, sebbene possa giungervi come conseguenza, l’essere funzionali o adattarsi alla società, non è portatore di soluzioni ready-made né di formule che valgono una volta per tutte…è una postura della mente e come tale ha dei principi e fondamenti teorici di riferimento, ha diversi metodi e metodologie che si possono applicare, ha molteplici esercizi che si possono apprendere e ripetere e replicare, è un dialogo e un domandare che può essere praticato da soli ma che trova la sua migliore espressione nella relazione, nell’incontro con l’altro in cui il personale coraggio di sapere si riflette in quello dell’altro in un tempo trasformativo e arricchente per tutti i soggetti.
©Sarah E. Bagliani, LAMENTEFUNAMBOLA